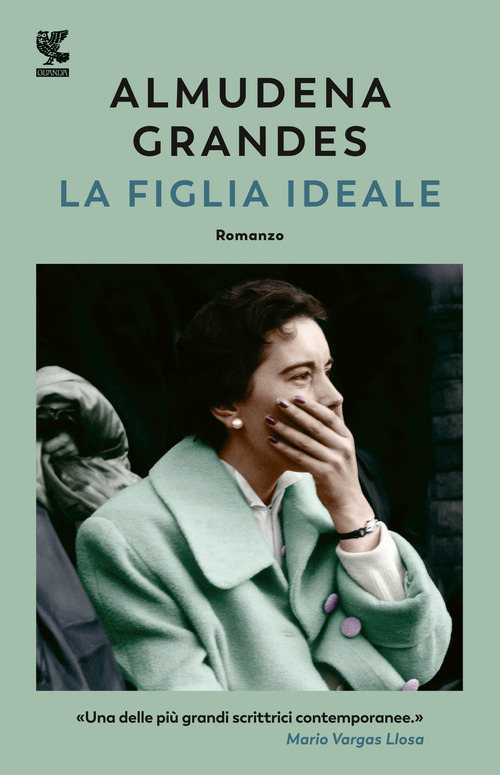
Recensione del libro: “La figlia ideale” di Almudena Grandes
“In fondo siamo fortunati a lavorare in un manicomio. Cosi non cambiamo aria quando entriamo e usciamo dal lavoro” con queste parole un amico e collega di Germàn descrive l’atmosfera sociale degli anni 50 in Spagna.
Nel romanzo, una storia di follia individuale e familiare – quella di Aurora Rodriguez Carbaillera, che uccide la figlia in preda ad un delirio paranoide infarcito di razzismo fascista diventa la metafora di un’epoca di follia collettiva, identificata dall’Autrice nel periodo franchista spagnolo.
Più volte nei suoi romanzi Almudena Grandes analizza i paradossi del franchismo spagnolo, gli anacronismi di quella lunga dittatura esclusa dal destino delle altre nazioni europee.
In questo romanzo la follia e l’insensatezza sono più forti ed evidenti nei burocrati spagnoli piuttosto che nelle ospiti del manicomio.
Germàn nel 1939, a diciannove anni, lascia la Spagna da fuggitivo, spinto dal padre medico, oppositore del regime franchista. L’unico salvacondotto per sfuggire alla guerra e a Franco il padre lo dà a German, nella speranza che il figlio possa raggiungere la Svizzera e lì continuare gli studi. Così accade, e molti anni più tardi, nel 1954, Germàn, contro la volontà della madre e degli amici spagnoli, torna in patria accettando un incarico in un manicomio femminile. La sua terra è ancora preda del regime franchista e lui dovrà conoscere e vivere una Spagna senza libertà, nel suo posto di psichiatra di un manicomio femminile dove le “ultime” – donne, pazze – sono segregate. Dovrà condurre uno studio sperimentale con uno dei primi farmaci per la schizofrenia, la clorpromazina. L’opposizione dei burocrati a questa sperimentazione e allo stesso miglioramento – alla liberazione – delle pazienti, rappresenta la chiusura di quel mondo, l’oppressione del regime fascista con la connivenza della Chiesa, ma non solo… rappresenta anche la rigidità di un pensiero bigotto e maschilista, dove la violenza inizia già dentro le mura domestiche.
Violenta è la storia di Aurora Rodriguez, la schizofrenica paranoide (realmente esistita) che uccide la figlia, “creata” come un esperimento perché fosse intelligente come un uomo e ariana, ma poi naturalmente non perfetta e perciò annientata dalla stessa madre.
Violenta è la storia di Maria, la nipote del giardiniere del manicomio. Maria non sa di aver perso i genitori in una strage franchista, non sa che loro erano oppositori del regime. Lei deve essere grata alle suore del convento perché la tengono presso di loro e la fanno lavorare, ma poi scopre di essere prigioniera e di non poter scegliere liberamente per la propria vita.
Nei numerosi piani di cui è costituito il romanzo, diverse questioni interrogano il presente: la differenza tra normalità e patologia, la follia al potere e il rapporto tra follia e potere, il predominio sulle donne e la discriminazione degli omosessuali…
Ancora altre storie incrociano quelle principali, come il destino della famiglia che accoglie Germàn in Svizzera. Ebrei scampati al nazismo che sono in attesa di un figlio disperso. Il dolore della guerra, della divisione di popoli e famiglie, dell’esilio e della perdita dell’identità attraversano completamente il romanzo. Sono le pagine più tristi e dolorose, quelle insuperate, non guarite.
La psichiatria e il suo rapporto con l’oppressione o la liberazione delle persone: questo è un tema antico ma attuale. La forza politica della cura rimane un tema ancora vivo, anche fra queste pagine.
Nelle storie come queste, la riflessione storica, sociale, umana diventa intreccio emotivo. Partendo da fatti realmente accaduti, in un’epoca storica precisa, piena di contraddizioni e di mancanze narrative, la Grandes ha saputo creare personaggi vividamente umani, pieni di incertezze e di vulnerabilità, che a tratti assumono una luce eroica.
“La storia della nipote del giardiniere era un minuscolo frammento della storia di Spagna. (…) Consegnandomela (…) aveva messo nelle mie mani un piccone affilato, uno strumento in grado di aprire una breccia nell’asfissiante urna di silenzio che rarefaceva l’aria che tutti respiravamo”